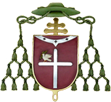Carissimi presbiteri, carissimi fratelli e sorelle tutti.
Nei giorni scorsi abbiamo riflettuto, nell’incontro del clero, sul passaggio che ci è chiesto nel cammino sinodale delle nostre Chiese in Italia e della nostra Chiesa di Ravenna–Cervia. Un passaggio che riguarda tanti aspetti della vita cristiana ed ecclesiale. E riguarda anche la vita dei presbiteri. Ci siamo ascoltati e confrontati in questo anno in modo particolare nel Consiglio presbiterale, ma anche nei due anni scorsi nelle assemblee del clero.
non si torna indietro
Il primo messaggio che vorrei ribadire è che dal cammino sinodale “non si torna indietro”: come Israele che, una volta uscito dall’Egitto, non può tornare nella terra del passato, con alcuni svantaggi e però con il vantaggio di essere obbediente alla chiamata del Signore. È lo Spirito del Signore che anche oggi ci indirizza verso una nuova realtà, in parte ancora da costruire. Siamo infatti chiamati a essere una Chiesa missionaria, dove tutti sono coinvolti per dare la propria testimonianza e il proprio contributo, rimanendo nella comunione, anche se la differenza di vocazioni, di carismi e di ministeri, può creare tensioni o conflitti. Vogliamo e dobbiamo rimanere cioè un Corpo solo dove il contributo di tutte le membra con pari dignità ci permette di essere una comunione nelle pluralità, come Cristo la vuole, Lui il nostro Capo.
una guida diversa, per la Chiesa conciliare
E come Mosè fu costretto ad ammettere durante il cammino nel deserto, c’è bisogno anche nel nuovo Popolo di Dio oggi di una guida diversa, condivisa. A Mosè furono dati i 70 anziani (Es 11,16ss), noi dovremo accogliere una pluralità di ministeri, di vocazioni e di attività. Sembrerebbe una cosa di buon senso: come si può guidare un popolo o una sua porzione locale, da soli? È necessario suddividere i ruoli in base alle competenze e alle disponibilità, come in qualsiasi società ben ordinata. Ma tra noi c’è qualcosa i più.
Si tratta di presentare un nuovo volto di Chiesa dove le parole che contano, le azioni importanti, sono di tanti, non di pochi, né di uno solo. La struttura della Chiesa, e del ministero ordinato in particolare, che ha le sue radici –dicono gli storici– nella riforma carolingia, poi gregoriana e infine tridentina, è arrivata fino al secolo scorso, seppure con adattamenti alle vicende storiche. Ancora al tempo del Vaticano II i nostri padri conciliari, Vescovi e teologi, venivano da una concezione della Chiesa come “societas juridice perfecta”, cioè non inferiore a qualsiasi altra società umana. Oggi con la Lumen Gentium e con la Presbiterorum Ordinis, molte concezioni teologiche si sono approfondite, altre sono state abbandonate, altre sono state riprese e riattualizzate dalla Chiesa delle origini.
Nell’ultimo passaggio di questa attraversata del deserto per arrivare alla terra promessa, ci troviamo nell’epoca post-conciliare davanti al messaggio e all’impostazione di papa Francesco, condivisa dai vescovi e dai partecipati agli ultimi sinodi della Chiesa universale, e anche dal sinodo (2021-2024) che ci ha consegnato l’ultimo Documento finale, lo scorso anno.
le prime comunità modello di missione
Ci è chiesto dallo Spirito santo e dal Magistero apostolico, come al tempo degli Atti degli apostoli, di uscire dal nostro cenacolo e senza paura affrontare un mondo ritornato pagano, raccontando di nuovo la nostra fede nel Signore Gesù Cristo, ultima e definitiva rivelazione di Dio. E ci è chiesto di allargare gli spazi e i cuori delle nostre piccole comunità a chi è disponibile a mettersi in ricerca o si trova in situazione di crisi e cerca un senso alle cose, o non ha dato ancora per persa la sua fede nutrita solo nei tempi della prima fanciullezza fino alla cresima. Le prime comunità ci possono essere di modello, con i quattro pilastri della loro “nuova via”: la comunione, la condivisione con i poveri, la preghiera, il pane spezzato dell’Eucaristia. Le prime comunità sono missionarie, perché hanno la coscienza chiara che tutto il mondo attorno non è cristiano, anche se ci sono dei credenti in altre religioni. E così sia gli apostoli come Pietro e Paolo, ma anche altri discepoli vengono inviati in missione, come Barnaba, Marco, Tito, Timoteo, e anche altri laici: le donne (come Lidia o Febe, At 16 e Rom16), le famiglie convertite (Aquila e Priscilla, At 18), alcune persone straniere convertite (Paolo ai Romani, cita 27 collaboratori tra i quali 8 donne, Rom 16). La forza dello Spirito in quei tempi era tanta, ma anche il coraggio e la franchezza dei testimoni e degli annunciatori, come Filippo e soprattutto Stefano, il protomartire. La persecuzione da parte del mondo esterno non mancava. Molti hanno creduto, non tutti allo stesso modo, qualcuno anche allora tradiva. Qualcuno usava i ministeri e i carismi per affermare sé stesso e ricavare spazi di potere nella comunità e forse anche nella società, per questo Paolo deve intervenire in modo pesante nella comunità di Corinto (cfr. 1 Cor 1), alla quale però fa dono dell’inno alla carità, che rimane una fonte di illuminazione e una provocazione per la Chiesa di tutti i tempi.
una chiesa sinodale
Ci è chiesto di edificare la Chiesa sinodale con una natura comunionale, che vive la sua identità di Popolo di Dio, che sa ascoltare e che distribuisce il pane spezzato della Parola e della Carità nelle piccole e grandi occasioni della vita quotidiana, che mobilita tutte le forze che ci sono, poche o tante, che si organizza a partire dalla comune dignità fondamentale di tutti i battezzati. Ma anche una chiesa che sa aprirsi e far vivere i suoi “corpi intermedi”, rappresentativi, cooperativi, nell’attenzione al ministero ordinato che pur essendo a servizio di tutti, sa suscitare le decisioni e nei passaggi che riguardano tutti, sa coinvolgere e ascoltare tutti.
L’immagine ce la fornisce la lettera agli Efesini, anche nel brano letto oggi: alcuni, –i ministri, gli apostoli, i profeti e gli evangelisti, i pastori e i maestri–, devono preparare tutti gli altri fratelli a compiere il grande Ministero, l’edificazione del corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Da Cristo “tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare sé stesso nella carità”. (Ef 4,10-16)
una guida sinodale
Dovrà avvenire un passaggio da una guida rispettata e obbedita, quasi sacra o almeno percepita come appartenente ad un’altra sfera rispetto ai laici, a una guida più sinodale, partecipata, condivisa con altre ministerialità che esercitano la loro responsabilità, come i ministeri istituiti, i ministeri di fatto antichi e nuovi e soprattutto condivisa con i diaconi. Non un passaggio normale, ma un grande attraversamento del mare Rosso, che potremo fare solo con la forza dello Spirito del Risorto. Infatti, non solo è il passaggio dal singolo “sacerdote addetto al sacrificio”, come nella tradizione ebraica e medievale, ma è il passaggio verso un ministero tripartito (Vescovo, presbiteri e diaconi) e verso la collocazione del prete nell’Ordine dei presbiteri. In una fraternità cioè che deve agire collettivamente, a servizio dello Spirito, della propria Chiesa particolare e della missione alle genti, animato dalla carità pastorale. Oggi riconosciamo infatti come insufficiente il basare la identità presbiterale solo sull’ “agire in persona di Cristo capo”, perché la dimensione cristologica deve essere in equilibrio con la dimensione ecclesiale, pneumatologica e missionaria del ministero ordinato. Superando così la antica distinzione tra sacro e profano, –propria delle religioni non del vangelo–, che non si può più applicare alla differenza tra clero e laici. Tutti siamo per il Battesimo e la fede, discepoli missionari, pescatori di uomini, edificatori di comunità, sale della terra e luce del mondo, con pari dignità (cfr. conclusione della lettera ai Romani, Rom 16, 1-6).
il parroco
Al presbitero, soprattutto se parroco, è chiesto di suscitare e coordinare i carismi, i ministeri e le attività pastorali e missionarie che lo Spirito dona alle Chiese, per essere tessitore di quella comunione organica che caratterizza l’unione delle membra nel corpo. Dove al singolo presbitero è chiesto di essere non un patriarca, ma un padre e un fratello maggiore; uno che ascolta, accoglie, promuove tutti i fedeli, presiedendo. Non uno che fa tutto e occupa tutti gli spazi, ma che avvia processi in comunità comunicando e informando, dando la parola ad altri, accettando le resistenze e i bisogni delle persone, con discernimento, aiutando i fedeli a condividere le decisioni alla luce di criteri di giudizio evangelici, prendendo infine delle decisioni, possibilmente condivise dal maggior numero e poi accompagnandole con il rendiconto di quanto si è attuato.
Un compito assai impegnativo, ma che assomiglia a quello di un padre di famiglia che ha figli maggiorenni e un coniuge a cui deve dare ascolto e rispetto, per arrivare a decisioni condivise che valorizzano tutti in famiglia e li arricchiscono della visione e delle proposte degli altri. Decisioni lente, faticose, ma più rispettose della dignità battesimale di tutti. Quel Battesimo che, come ci ricorda S. Agostino, è il nostro vero titolo di salvezza, mentre al contrario l’essere pastori è titolo di responsabilità e di rischio, davanti al Signore.
“io sto in mezzo a voi come colui che serve”
Abbiamo ascoltato il vangelo di Luca che ci rende conto del fatto che gli apostoli, benché fossero ormai alla fine del cammino insieme, poco prima della Pasqua, stavano ancora discutendo su chi fosse da considerare il più grande. E Gesù reagisce: “Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure, io sto in mezzo a voi come colui che serve”. È la parola che il Signore ci consegna anche per la Chiesa di oggi e del futuro. Essa va contro uno dei bisogni più forti dell’animo umano: quello di affermarsi, dominare, essere padroni di qualcosa o di qualcuno, ricevere riconoscimento, ricevere qualche tratto di gloria. È questa la lotta spirituale di sempre dei ministri ordinati, chiamati a imitare da vicino il Signore Gesù, mite e umile, venuto per servire non per essere servito. Ministri cioè servi, in una Chiesa serva, il cui volto così sarà più attraente per gli uomini e le donne di oggi.
Ce lo dobbiamo ripetere: non capi ma servi, non grandi ma piccoli, non padroni ma fratelli, non maestri ma portavoce dell’unico maestro, e anche non voci isolate e autoreferenziali, ma inserite in un coro dove non prevalgono i solisti, ma prevale il noi sull’io. Il noi del presbiterio, sempre con il vescovo, il noi della Chiesa universale e locale, il noi degli organismi di partecipazione e delle aggregazioni ecclesiali, il noi delle comunità parrocchiali, raggiunto magari con un tempo anche lungo di dialogo e confronto. Un noi, infine, che promuove altri ministeri, piccoli o grandi, che propone impegni e responsabilità per far cresce così vocazioni laicali di tutti i tipi, con un occhio particolare alle vocazioni consacrate, al diaconato, al ministero presbiterale.
Ce lo conceda il Cristo Pastore e Sposo, Capo e Servo della sua Chiesa (PDV 21-33)