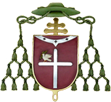Turismo e accoglienza / 7
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 9/2013
Le domande che ci pongono i turisti: il Sacello di San Vitale
Una delle domande più frequenti che ci pongono i turisti riguarda l’antico Sacello o Pozzo di San Vitale. I resti di questa antichissima struttura si possono facilmente riconoscere ancora oggi all’interno della nostra splendida basilica bizantina, consacrata dall’arcivescovo Massimiano il 17 maggio del 547 o 548. Infatti i visitatori, nel momento in cui volgono lo sguardo incuriosito in corrispondenza del nicchione quasi contrapposto al presbiterio, comprensibilmente chiedono: ‘Ma questo pozzo d’acqua è un fonte battesimale?’. Penso che sia utile, anche per il lettore ravennate, fornire in questa rubrica una risposta.
Secondo la leggenda proveniente dallo Pseudo Ambrogio Vitale di Milano militò nell’esercito romano ai tempi dell’imperatore Nerone. Egli, trovandosi di guarnigione a Ravenna e scoperta la sua adesione al cristianesimo, sarebbe stato gettato in un pozzo che successivamente fu riempito di pietre. Sembra che il pozzo del martirio si trovasse proprio nel luogo dove attualmente si apre un bacino pieno d’acqua, nel quale i turisti stessi amano gettare una monetina come buon augurio. La festa di san Vitale si celebra il giorno 4 novembre. Tale culto ambrosiano si diffuse così a Ravenna, nel momento in cui si trasferì da Milano nella nostra città la corte imperiale (402). In quel luogo, in ricordo del martirio, fu eretto un sacello che in origine consisteva in un aula rettangolare lunga m. 8,48. Un sacello è un ambiente di piccole dimensioni e di carattere sacro. Può avere varia forma e destinazione, come quella di custodire le reliquie di un santo particolarmente venerato. I sacelli venivano chiamati anche martyria quando costruiti sulla tomba di un martire. Nel 1911 – sotto la direzione del professor Giuseppe Gerola della Regia Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna ‘ iniziarono gli scavi nel deambulatorio della basilica per il ripristino delle quote pavimentali originali. In corrispondenza dell’esedra fronteggiante la terza campata, a partire dal presbiterio in senso orario, venne alla luce il mosaico pavimentale (m. 1,18 x 1.04) del piccolo oratorio in onore del santo martire milanese e – immerso nell’acqua – il basamento dell’altare primitivo. Mons. Mario Mazzotti ricordava che però non si rinvenne ”nessuna traccia di una tomba” dello stesso santo venerato – come sostenne con provate argomentazioni lo stesso illustre studioso – anche a Bologna (si veda M. Mazzotti, ‘S. Vitale. Storia e leggenda’, in ‘L’Argine’, 5 novembre 1966). Il brano musivo, il quale negli anni Settanta del secolo scorso era collocato nel matroneo, nel 1982 è stato accuratamente restaurato sempre dalla locale Soprintendenza e ricomposto nei pressi del sacello su intelaiatura metallica. Il pavimento è costituito da tre campiture a mosaico che circondano la base marmorea dell’altare. Quella a sud presenta una rete di svastiche disposte in modo obliquo che formano negli spazi di risulta losanghe alternativamente verticali e orizzontali. La campitura nord – non integra – è decorata da quadrati, ellissi e cerchi tracciati da cordoni intrecciati tra loro. Il riquadro centrale – al di sotto dell’altare – raffigura un kantharos (vaso) circondato da elementi vegetali come ramoscelli di fiori, frutta e volatili. Fra gli animali paradisiaci si possono ammirare i pavoni simbolo di vita eterna. Al di sopra dell’altare si trova una fascia con treccia a due capi. Infine i riquadri sono circondati e collegati tra loro da una cornice nei colori dell’iride con tessere disposte a spigolo. Secondo i più autorevoli studi critici il mosaico del piccolo oratorio è da riferire all’età placidiana (prima metà del V sec.) ed è eseguito da maestranze ravennati di qualità. Quello che solitamente colpisce i visitatori è la straordinaria scioltezza nella resa figurativa ed eleganza decorativa che si legge chiaramente nel disegno e nella dolce cromìa di tutta la partitura musiva di impronta ancora classica. Infatti questo mosaico pavimentale è composto di tessere marmoree e da minutissimi inserti di pasta vitrea che impreziosiscono il piumaggio degli uccelli. Di fronte a tale ricchezza e varietà di colori scrive la studiosa Raffaella Farioli nel suo volume ‘Pavimenti musivi di Ravenna paleocristiana’ (1975): ”Considerando il pannello nel suo complesso, notiamo come tuttavia si annunci già quella tendenza allo schematismo che trionferà nelle composizioni assiali e araldiche del VI secolo, schematismo che non offrirà alcun suggerimento ambientale”. Inoltre pannelli con animali mansueti come i pavoni, sempre secondo l’autrice, per il significato che esprimono e per la loro collocazione presso la zona sacra, rivelano un legame significativo con uno spazio degno di sosta e di meditazione per il fedele. Come si è detto, in loco si è scoperto il basamento dell’altare originario. Esso mostra ancora gli innesti delle quattro colonnine che sostenevano la mensa e – al centro – il piccolo incavo per l’alloggiamento delle reliquie.
Il bacino serve anche per il drenaggio dell’acqua che altrimenti invaderebbe la basilica, il cui piano è al di sotto del livello della falda freatica. Da esso, infatti, si diparte una conduttura attraverso la quale – per mezzo di una pompa – viene aspirata l’acqua quando raggiunge un livello prestabilito. L’impianto di aspirazione è contenuto nel piccolo abitacolo che si vede addossato al muro del cortile a sinistra, andando verso il mausoleo di Galla Placidia.
Queste annotazioni storiche e tecniche sul più antico sacello di San Vitale hanno un impatto molto positivo sulla sensibilità culturale e religiosa dei turisti. Così essi arricchiscono notevolmente la loro conoscenza anche della stessa storia devozionale e conservativa dei monumenti che stanno visitando.
Filippo Treré – Opera di Religione della Diocesi di Ravenna