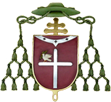Le collezioni del Museo Arcivescovile/2
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 15/2011
‘Un’altra croce dee notarsi, la quale si espone su l’Altar maggiore il Venerdì Santo‘
(F. BELTRAMI)
Al secondo piano del Museo Arcivescovile, nella sala circolare ricavata all’interno della torre Salustra, sono presentate tre significative croci del tesoro della cattedrale. Preziosi e raffinati oggetti di oreficeria esse appartengono a diversi periodi storici e testimoniano, nel tempo, il valore della croce come oggetto liturgico e di devozione. Esse sono la croce di Agnello, la croce di maestro Andrea e la croce reliquiario della Sacra Spina.
La croce detta del vescovo Agnello
‘Il beatissimo Agnello fece una grande croce d’argento nella chiesa Ursiana, sopra la cattedra alle spalle del vescovo’. Questa notizia, tramandataci dal Liber Pontificalis ha suggerito l’attribuzione di questa croce stazionale all’Arcivescovo Agnello, pastore della chiesa ravennate tra il 556 e il 569. Inoltre molti studiosi, tra questi Mons. Mazzotti, ritengono che essa sia opera del VI secolo. La croce tuttavia presenta numerosi interventi di restauro che rendono difficoltosa una datazione certa. Certamente appartengono a fasi successive i due medaglioni posti al centro dei bracci che presentano la resurrezione di Cristo e la Vergine orante.
L’originaria iconografia della resurrezione, fedele ai testi evangelici, presenta la tomba vuota e le mirofore accorse al sepolcro; al proposito un interessante confronto va fatto con l’immagine della Resurrezione in Sant’Apollinare Nuovo. Questa antica iconografia lascia spazio, nel tempo, ad una interpretazione diversa, meno fedele al racconto evangelico, nella quale vediamo ‘ come qui nel clipeo centrale della croce – il Cristo, vittorioso sulla morte mentre esce dal sepolcro.
L’immagine della Madonna, considerata precedente agli interventi del 1559 che avrebbero realizzato l’immagine del Cristo risorto e il braccio inferiore della croce, ricalca un’iconografia antica che a Ravenna trova riscontro nell’immagine della Vergine dei mosaici medievali dell’Ursiana (mosaico ora all’interno delle collezioni museali) e nella Madonna Greca, splendido bassorilievo del XII secolo venerato nella Basilica di Santa Maria in Porto.
Lungo i bracci della croce 40 clipei, 5 su ogni braccio, presentano la figura di santi a mezzo busto con il capo nimbato.
Da ultimo vale la pena citare un passo tratto da Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna di Francesco Beltrami, che, nel ‘700, documenta l’uso liturgico di questa croce: ‘E’ degna parimente di osservazione una croce d’argento chiamata di S. Agnello (…) la quale si espone nelle Feste a cornu Evangelii dell’Altar maggiore, e portasi anche avanti al Clero in alcune Processioni, che si fanno d’intorno alla Chiesa‘.
La croce di maestro Andrea
La croce processionale di maestro Andrea, splendido esempio di arte orafa, è opera del XIV secolo. Le immagini si articolano su due lati e presentano il Crocifisso e Sant’Apollinare, primo vescovo della chiesa ravennate alla fine del II secolo.
Sul fronte, in alto, sopra al Crocifisso, è la figura del Cristo benedicente con in mano il codice del vangelo. Una citazione evangelica accompagna l’immagine: ‘Ego sum lux mundi‘, Io sono la luce del mondo. Alle estremità della croce, secondo una consueta iconografia, abbiamo le immagini dell’Addolorata, di Giovanni e, in basso, di Maria Maddalena.
Il basamento presenta una significativa scritta che riassume il senso salvifico della croce di Cristo: Salve Crux XPI benedicta redemptio mundi, Salve o croce benedetta di Cristo, redenzione del mondo.
Altrettanto interessante è il retro della croce dove le immagini simboliche dei quattro evangelisti fanno da cornice alla figura del protovescovo. L’immagine di Apollinare, unito al mistero della croce, ricorda una immagine ravennate ben più famosa, ovvero quella che ancor oggi ammiriamo nel catino absidale di Sant’Apollinare in Classe. Il protovescovo, rappresentato in abiti liturgici e nella posa dell’orante, è associato, nella celebrazione del cultoeucaristico, al mistero glorioso della passione, morte e resurrezione del Cristo.
E’ sempre il Beltrami a documentarci un importante uso di questa croce all’interno della liturgia ravennate. Egli infatti ricorda come essa venisse esposta il Venerdì Santo sull’altare maggiore della cattedrale di Ravenna: ‘Un’altra croce dee notarsi, la quale si espone su l’Altar maggiore il Venerdì Santo‘.
La croce reliquiario della Sacra Spina
Questa croce processionale, che gli studi datano tra il XV e XVI secolo, si configura come un prezioso reliquiario; al centro dei bracci, all’interno di una teca, sono custodite due spine della corona di Cristo qui conservate per essere venerate dai fedeli.
‘Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, re dei Giudei!‘ (Mt 27, 27-29).
Formelle polilobate alle estremità dei bracci della croce mostrano figure di santi e di sante. Sul recto esse sono eseguite a sbalzo, mentre sul verso sono decorate a niello. Alla base vi è un tempietto esagonale, di fattura raffinatissima dove, all’interno di nicchie conchigliate, sono santi e sante appartenenti all’ordine francescano.
GLI ANTICHI MOSAICI MEDIOEVALI DELL’URSIANA
Rimanendo in tema pasquale vale ora la pena ricordare i lacerti musivi che provengono dall’abside dell’antica basilica Ursiana, un ciclo di immagini risalente al 1112, al tempo dell’arcivescovo Geremia (1111-1118) e perduto definitivamente durante il rifacimento settecentesco della cattedrale. Solo sei sono i mosaici a noi pervenuti. Una iscrizione, posta nell’abside, datava il mosaico: Hoc opus est factum post partum Virginis actum anno milleno centeno post duodeno, Questa opera fu fatta nel millecentododicesimo anno dopo il parto della Vergine.
L’unica possibilità per conoscere il ricco programma iconografico absidale e per intuire lo splendore dell’opera di cui questi lacerti facevano parte ci è data dalle testimonianze precedenti al loro crollo. Un disegno dello stesso Gian Francesco Buonamici, l’architetto incaricato di rinnovare l’antica fabbrica, venne riprodotto in incisione e pubblicato nel volume La Metropolitana di Ravenna. Esso venne realizzato proprio allo scopo di documentare un’opera destinata ad essere per sempre perduta. Così è scritto in calce all’incisione: ‘Musaico, che si vedeva nel Coro della Chiesa Metropolitana di Ravenna, il quale minacciando ruina, per conservarne la memoria, l’anno 1741 fu dal Cav. Gianfrancesco Buonamici Architetto della nuova Metropolitana esattamente disegnato a vantaggio degli Eruditi‘.
Il catino absidale presentava all’ammirazione e alla devozione dei fedeli vari temi strettamente legati alla fede e alla storia della chiesa ravennate. Tema centrale di tutto il ciclo musivo era la Resurrezione di Cristo a cui è tutt’ora dedicata la chiesa cattedrale.
Al centro del catino absidale era rappresentata la Resurrezione di Cristo nell’iconografia tipicamente orientale della discesa agli inferi: Gesù risorto, vittorioso sulla morte, calpesta le porte dell’inferno e dona vita nuova a tutto il genere umano. Ai lati erano immagini legate al ciclo pasquale: le mirofore che al mattino di Pasqua si recano al sepolcro e l’angelo che annuncia loro la resurrezione (Mt 28,1-8), i soldati posti a guardia della tomba (Mt 27, 62-66), Pietro e Giovanni al sepolcro (Gv 20, 1-10). Nell’arco absidale, in continuità con il tema della resurrezione, era raffigurata l’ascensione al cielo (Lc 24, 50-53).
Questo tema centrale era affiancato da un altro più propriamente ravennate incentrato sulla vita di Sant’Apollinare, i miracoli da lui compiuti, la sua morte, la sua sepoltura.
Il registro inferiore dell’abside presentava il vescovo Apollinare, nella posa dell’orante, al centro dei primi undici vescovi di Ravenna, chiamati vescovi colombini secondo la leggenda che li voleva scelti alla sede episcopale ravennate da una colomba che, al momento dell’elezione, si posava sul loro capo. Sullo stesso registro erano inoltre altri santi e vescovi tra i quali ricordiamo Vitale, Massimiano e Orso.
Un registro mediano, che comprendeva le cinque finestre absidali, oltre a scene della vita di Sant’Apollinare, presentava la Vergine orante, San Giovanni Battista, San Barbaziano, Sant’Ursicino i quali venivano così ad assumere una posizione di rilevanza rispetto a tutti gli altri santi qui raffigurati.
Tra i volti giunti fino a noi vanno notati e ricordati in particolare quelli di Pietro e Giovanni. I due discepoli sono qui raffigurati in un preciso momento narratoci dal Vangelo di Giovanni: ‘Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa‘ (Gv 20, 1-10).
Il mosaico medioevale riportava proprio questo preciso momento in cui Pietro stava entrando nel sepolcro. Il suo volto è incorniciato da tessere scure per evocare le tenebre all’interno della tomba vuota. Dietro a lui stava Giovanni, il discepolo che Gesù amava.
Giovanni Gardini
Commissione d’Arte Sacra Diocesana
giovannigardini.ravenna@gmail.com
ARTICOLI CORRELATI:
Museo Arcivescovile: storia e collezioni