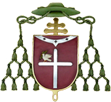La Fede dei Magi’ a Ravenna
Percorsi di arte e fede
Sono queste le parole che ogni anno, nella solennità dell’Epifania, risuonano nella celebrazione dell’eucarestia, nella preghiera sulle offerte, parole dense, antiche, che illuminano di un significato profondo i doni dei Magi e i doni posti sull’altare. Questa preghiera ci permette di cogliere in una nuova luce le molteplici rappresentazioni dei magi che nei secoli sono state prodotte dall’arte cristiana.
Nel Museo Arcivescovile di Ravenna l’adorazione dei Magi è presente nella Capsella dei Santi Quirico e Giulitta, un reliquiario di marmo databile alla prima metà del V secolo. Sempre all’interno del Museo la presenza dei Magi può essere ricordata nella Cattedra d’Avorio di Massimiano: in questo caso dobbiamo parlare di un’assenza, dato che la scena dell’adorazione dei Magi è mutila. Sulla fronte dello schienale ammiriamo la Vergine in trono, con il bambino, la stella, elementi importanti dello schema iconografico di questa scena ai quali anticamente andava affiancata la formella con i Magi che offrivano doni.
La raffigurazione più importante dell’adorazione dei Magi compare nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Questa immagine, monumentale per le dimensioni e la preziosa tecnica del mosaico, merita una particolare attenzione in quanto è il risultato di due committenze diverse. Maria in trono con il Bambino, appartiene alla prima fase del mosaico, cioè all’epoca teodoriciana, quando nella Basilica veniva celebrato un culto ariano che non riconosceva la divinità del Cristo, i re Magi invece risalgono alla committenza dell’arcivescovo Agnello quando, morto il re Teoderico (526) e sconfitti i Goti (540), la basilica passò per editto imperiale alla Chiesa Ravennate. Il vescovo Agnello (556-569), fedele all’ortodossia e, come il suo predecessore Massimiano, in comunione con la chiesa di Roma intervenne sul primo registro di mosaico e lo epurò di quelle immagini che, si presume, erano troppo connotate sia dal punto di vista politico sia religioso e mise al loro posto le due straordinarie processioni dei santi e delle sante. La scena dei Magi, posti in apertura del corteo delle sante, veniva così a completare quello schema iconografico che accostava all’immagine della Vergine in trono i sapienti venuti dall’Oriente e ad illuminare il mosaico regale di Maria con Gesù posto sul suo grembo. La Vergine diventava a pieno titolo la Theotókos, la Madre di Dio, titolo cristologico formulato nel terzo Concilio Ecumenico, svoltosi ad Efeso del 431. Geniale fu l’arcivescovo Agnello, nella sua opera di teologo- committente, che seppe così manifestare pienamente il nuovo culto celebrato nella fede ortodossa, in chiara contrapposizione con l’eresia ariana.
Vorrei concludere questa breve riflessione sull’iconografia dell’adorazione dei Magi – percorso culturale e spirituale che durante le vacanze natalizie può diventare oggetto di visita nei monumenti di Ravenna – con le parole che San Pietro Crisologo, vescovo ravennate nella prima metà del V secolo, ha pronunciato nel Sermone 160, quarto discorso sull’Epifania, affinché le sue parole poetiche, ricche di carità pastorale, ci guidino, in queste feste natalizie, all’incontro di Gesù, vero Dio e vero Uomo: ‘Quantunque nello stesso mistero dell’incarnazione del Signore siano sempre apparsi chiari i segni della sua divinità, la solennità odierna in molti modi spiega e rivela tuttavia che Dio è venuto in un corpo umano, perché i mortali, avvolti sempre nell’oscurità, non perdano, per la loro ignoranza quello che meritarono di avere e di possedere per una grazia così preziosa. Infatti, Colui che volle nascere per noi non volle essere da noi ignorato; perciò si rivela così, affinchè il grande mistero della pietà non diventi una grande occasione di errore. Oggi il mago trovò vagiente nella culla Colui che cercava fulgido tra le stelle.
Giovanni Gardini