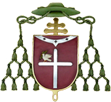La donna nell’Ebraismo
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 12/2011
Lo scorso 15 marzo al Cinema Corso di Ravenna, nel primo dei martedì di Sant’Apollinare, dedicati al tema della donna nelle religioni monoteistiche, si è tenuto un incontro con l’ebraista dott.ssa Claudia Milani, sul tema ‘La donna nell’ebraismo’. L’organizzatore, padre Dino Dozzi, ha introdotto affermando di essere stato indotto ad affrontare l’argomento dal fatto che la donna è ancora discriminata in tanti paesi del mondo e anche presso di noi non ha ancora ottenuto tutta la considerazione che merita. Ha presentato l’ospite Maria Angela Baroncelli, insegnante di ebraico biblico; essa ha spiegato che la ragione del suo impegno nell’insegnamento della lingua ebraica e nell’ebraismo è il rapporto unico che lega cristiani ed ebrei.
Claudia Milani ha esordito affermando che l’ebraismo è considerato una religione maschilista, ma bisogna superare questi luoghi comuni. È vero infatti che i testi sacri dell’ebraismo risentono della cultura in cui sono nati, ma nel primo capitolo della Genesi la donna è presentata come contrapposta all’uomo, e non inferiore a lui. Nel cap.31 dei Proverbi si parla della ‘donna di valore’ e di essa si danno le caratteristiche: infonde fiducia e felicità, governa la casa e si preoccupa per la famiglia, lavora costantemente, soccorre chi ha bisogno, parla con saggezza. Nel Seder di Pesah (il pranzo pasquale) quando si commemora la liberazione del popolo ebraico, accanto ai tre patriarchi vengono menzionate anche le quattro matriarche, Sarah, Leah, Rachele e Rebecca e questo per riconoscere la loro grande importanza nella storia del popolo ebraico. Tutti i brani biblici sono commentati dalla tradizione rabbinica. Sara genera un solo figlio in tarda età (Gn. 21, 7), Isacco, ma l’interpretazione rabbinica la pone in prospettiva universale, come madre di moltitudini. Quando Isacco si sposa, la nuvola che proteggeva la sua tenda, scomparsa alla morte di Sara, ricompare all’arrivo di Rebecca: è la presenza di Dio che si manifesta anzitutto nelle donne. Nel racconto biblico incontriamo molte importanti figure femminili che hanno preso iniziative per portare avanti la storia della salvezza. Una figura forte e vincente è quella di Deborah (in Giudici 4-5), giudice in Israele e profetessa. Debora è protagonista del famoso episodio in cui Barak, per suo ordine, marcia contro Sisara, ma, a causa della sua debolezza, Debora gli profetizza che il Signore avrebbe fatto cadere Sisara nelle mani di una donna. Altre due ebree, Elisabetta madre di Giovanni Battista e Miriam o Maria, madre di Gesù, si trovano nelle Scritture cristiane, ma si comprendono pienamente solo se viste nell’orizzonte ebraico. Elisabetta è equiparata ad Anna, madre di Samuele, e ad altre donne bibliche nel desiderio di un figlio che Dio le concede rovesciando la sua sorte. Miriam di Nazaret osserva tutti i precetti dell’ebraismo. Avvia Gesù al suo bar-mitzvà accompagnandolo a discutere coi dottori del Tempio, come era richiesto a tutti i ragazzi ebrei. Maria rimarrà poi sempre vicina al figlio con discrezione, lo accompagnerà fino alla morte in croce, come le donne ebree accompagnano padri, figli, sposi nelle loro imprese per la storia della salvezza.
Claudia Milani ha poi parlato dell’interpretazione rabbinica di Mishna e Talmud che si occupa di queste figure di donne bibliche: Dio, spiegano i maestri d’Israele, ha creato la donna non dalla creta, ma dalla costola di Adamo, e questo significa che le ha donato maggior intelligenza che al maschio. Le ha donato anche più fede, infatti è la donna che trasmette l’ebraicità ai figli, è la loro prima insegnante di precetti religiosi. La realizzazione della donna è il matrimonio, ma lo è anche per l’uomo: infatti il precetto impone a tutti di sposarsi e avere figli. Se marito e moglie si amano di amore autentico, la Shekinah, cioè la presenza di Dio, è con loro.
Nell’ebraismo contemporaneo l’ebreo è di discendenza matrilineare perché l’ebraismo dà molta importanza alla prassi, cioè al corretto agire. Nelle sinagoghe italiane, ortodosse, non ci sono donne rabbino, come fra i conservativi americani; ma la liturgia ebraica si svolge su due filoni, quello pubblico e quello familiare. La donna ha un ruolo secondario nella liturgia pubblica, ma primario in quella familiare. Ha il compito di accendere i lumi dello Shabbat, come segno di passaggio dal tempo profano al tempo sacro. Infatti la donna è più vicina all’alternanza dei tempi di Dio in quanto ha in sé biologicamente una forma di scansione del tempo che le permette questa comprensione in maniera istintiva, non con lo studio come avviene per l’uomo. Le norme di purità, che hanno valore sacrale e non etico, riguardano la donna perché essa, dando la vita, passa da una condizione sacra a una profana. Se per l’uomo la circoncisione segna nella carne l’ingresso nell’ebraismo, per la donna non ce n’è bisogno, perché essa ha già in sé questo valore sacrale. Il Tempio di Gerusalemme era l’unico luogo per i sacrifici, ma, una volta distrutto, è stato sostituito dalle case, divenute luogo di culto, con la tavola come altare, dove si svolge la liturgia domestica di cui la donna è ministro.
Giovanna Fuschini
ARTICOLI CORRELATI:
La donna nella religione musulmana
La donna nella religione cristiana
I Martedì di S. Apollinare ‘ Primavera 2011