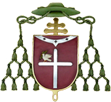La donna nella religione cristiana
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 13/2011
Una lettura corrente attribuisce alla religione cristiana molta responsabilità nella marginalità della donna nella storia e nella società. Ma è corretto? O non è, piuttosto, solo, per l’appunto, una lettura un po’ miope, in parte, se si vuole, corroborata da una sistemazione e interpretazione dei testi sacri in cui le donne hanno avuto un ruolo residuale? Conviene interrogarsi in proposito. Adriana Valerio, teologa, docente di Storia del Cristianesimo presso al Facoltà di Lettere dell’Università Federico II di Napoli, relatrice, lo scorso 22 marzo al Cinema Corso di Ravenna, per i ‘Martedì di S. Apollinare’, sul tema ‘La donna nelle religioni monoteiste’, è impegnata, ormai da anni, in un progetto di studi internazionale, da lei diretto, volto a ‘dare spazio allo sguardo femminile nell’interpretazione dei testi sacri’ e ritiene che la marginalità della donna sia una questione più di immagine che reale: a ben vedere nella realtà storica e socio-culturale occidentale la donna avrebbe avuto ruoli determinanti che hanno, però, mancato di visibilità. Ma se provassimo a cambiare ottica? Proprio a cominciare dal Cristianesimo che, nei secoli, ha permeato l’Occidente ed è accusato di aver proposto un prototipo di subalternità femminile attraverso il modello di Maria, silenziosa e obbediente: si tratterebbe, infatti, ancora, solo di un’immagine. Se solleviamo questo velo troviamo la donna come soggetto concreto e reale che opera nello spazio cristiano. Ecco emergere, allora, due ruoli autorevoli, nei quali la donna esprime al pieno la propria dignità di persona, perfettamente integrata nella storia: la parresia, ossia la libertà di parola e la diaconia, ossia il servizio, l’aver cura di.. La libertà di parola, che non è per nulla scontata (basti pensare alle società orientali, integraliste, attuali) è riconosciuta alle donna fin dalle pagine del Vangelo: anzi Gesù stupisce, portando a compimento l’antica legge (l’ebraismo già conferisce alla donna una sua dignità, vincolata, però, alla fecondità-maternità) anche in questo: le donne interloquiscono con lui al pari degli uomini, perfino le pagane, come la Cananea. Le donne sono le discepole che non abbandonano Gesù quando è sulla Croce, lo servono e ne hanno cura fino alla fine e, così, sono anche le prime testimoni della Risurrezione; nelle prime comunità cristiane supportano gli apostoli e contribuiscono con i loro beni e servizi (diaconia), inoltre accolgono nelle loro case. Paolo ha accanto a sé diaconesse che menziona ed elogia nei suoi scritti (benché ciò sia poco noto, essendo stati rimarcati tratti più critici nelle sue lettere). Nel Medioevo alcune donne cristiane predicano, come Ildegarde di Bingen, addirittura, su designazione vescovile, o come Domenica da Paradiso a Firenze, discepola di Savonarola, scrivono trattati, lettere ai Papi, perfino redarguendoli, come Brigida, laica! La dimensione della diaconia femminile, poi, seppur intesa come mero servizio, non (più) inserita nella gerarchia ecclesiastica, rimane una costante nei secoli, si pensi a Maria Longo che, a Napoli, nel ‘500, fonda l’ospedale degli incurabili, e ha una rinnovata vitalità nel ‘7-800 con il fiorire delle congregazioni femminile dedite agli ultimi, agli ospizi, agli orfanotrofi, agli educandati, fino a Teresa di Calcutta. Tenuto conto del processo di inculturazione della religione cristiana nella civiltà greco-romana (certo giuridicamente più avanzata e meno insensibile alla dignità femminile di quelle limitrofe o barbare) dove, comunque, l’autorità era saldamente in mani maschili, si può ben sostenere che il Cristianesimo, riconoscendo alla donna ruoli autorevoli, alternativi a quelli tradizionali, ha preparato, nei secoli e, si noti, proprio a partire dall’Occidente, il terreno per il pieno raggiungimento di pari dignità e diritti.
Elena Soetje Baldini
ARTICOLI CORRELATI:
La donna nella religione musulmana
La donna nell’ebraismo
I Martedì di S. Apollinare ‘ Primavera 2011