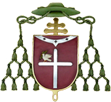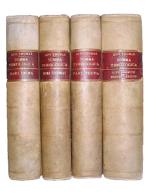
Educazione: Che voglia di possederti!
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 24/2011
Il sig. Mirro Amoni, collaboratore dell’Ufficio di Pastorale del Lavoro della nostra Archidiocesi, ha scritto cinque riflessioni scaturite dalla 46° Settimana Sociale di Reggio Calabria.
Sono cinque note a carattere apologetico, che si ispirano alla filosofia dell’educazione secondo la dottrina tradizionale del S. Dottore S.Tommaso d’Aquino, derivate dalla ‘Summa’. Le pubblichiamo, a puntate, a partire da questo numero.
La conoscenza delle cose
Quando si riflette sui percorsi, sui modi, sulle strategie dell’educare, ci si pone generalmente in una situazione relazionale: io, soggetto educatore o educando, di fronte a un altro soggetto, parimenti educatore o educando. L’acutezza intuitiva del soggetto educatore può arrivare al seguente enunciato: educo l’altro nella misura in cui mi sforzo di educare me stesso. Ed è vero.
Educare se stesso è buona cosa, ma è necessario convenire che per la buona educazione di se stesso si debba far riferimento alla connotazione della conoscenza vera. Ora, la conoscenza vera è data in modo evidente dall’adeguazione dell’intelletto al ‘proprium’, al ‘cuore’, alla specificità della ‘cosa’ (oggetti, accadimenti, persone’) che è posta in esistenza, e in quanto essa è posta in esistenza. La ‘cosa’, in quanto posta in esistenza, è desiderata proprio perché è conoscibile e dunque è aperta alla facoltà intellettiva, che la riconosce come buona, vera, appetibile, prima ancora che su di essa sia formulato un qualsiasi giudizio.
Ogni cosa esistente possiede in sé, e solo in sé, la verità del suo costitutivo fondamentale relativo al proprio esistere. Con essa deve misurarsi l’intelletto; alla sua verità dovrà approssimarsi l’intelletto di colui che si sforza di educare se stesso.
La verità nascosta nella ‘cosa’ esistente è conoscibile dall’intelletto. In che modo? L’intelletto conosce tale verità attraverso momenti diversi e ordinati. Dapprima esso riconosce ed interpreta i segni, i simboli (immagini, parole, suoni’), con cui la ‘cosa’ esistente si esprime. Poi esso indirizza il significato dei segni e dei simboli a specificare la bontà di cui essi sono portatori. Infine, esso perfeziona la forza del riconoscimento, attingendo alla Rivelazione, come a fonte originale del proprio essere e a sostegno della propria specifica attività interpretativa.
Talora, si dice che educare equivale a seguire le regole del momento o le tendenze del gruppo. Ciò è plausibile, quando tali regole e tali tendenze attengono alle circostanze, che sono da considerarsi via interpretativa dei segni delle cose. Ciò è errato, quando tali regole e tali tendenze assurgono a principi di per sé evidenti, capaci di causare l’azione dell’educare.
Ancora, taluni dicono che educare equivale a conciliare ‘valori’ condivisibili sostenuti da regole, o che diano vita a regole di convivenza sociale. Ora, il ‘valore’ condivisibile altro non è che la verità mediata ed estesa nel tempo. Ma la mediazione è complessa e frammentabile. Essa non appaga la sete di verità assoluta che è propria dell’intelletto. E’ esatto affermare, dunque, che è necessario condividere a priori ciò che il valore ‘rappresenta’: una verità originale di per sé evidente, i cui effetti connotativi conviene concordare che debbano essere attingibili senz’altro per via mediativa.
Quando si chiede se è valida la regola, dettata dal proprio cuore o dalle proprie inclinazioni, di educare secondo valori condivisi, è opportuno riconoscere che questa è senz’altro una regola valida, purché la sensitività del cuore e delle inclinazioni presti ossequio alla ragionevolezza delle ragioni dell’intelletto.
Mirro Amoni