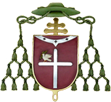Le collezioni del Museo Arcivescovile/3
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 19/2011
La sala del Calendario pasquale e della Capsella, al primo piano del Museo Arcivescovile, custodisce due pezzi d’eccezione. Il primo è un calendario pasquale, inciso nel VI secolo su una lastra marmorea, mentre il secondo è una capsella di V secolo, un reliquiario, proveniente dalla chiesa si San Giovanni Battista.
Il Calendario Pasquale
Il calendario pasquale, come dice il nome stesso, serviva per datare la celebrazione della Pasqua per gli anni 532-626 ed è documento raro e prezioso al tempo stesso. Al centro di una raggera costituita da 19 spicchi è la croce, centro del cosmo, da cui parte il computo per la celebrazione liturgica della Resurrezione di Cristo.
La lastra marmorea, di cui non conosciamo l’originaria collocazione, è da tempo attestata nel Duomo di Ravenna ed è significativo poterla mettere in relazione con esso, dedicato fin dalla sua fondazione proprio alla Resurrezione. Il Liber Pontificalis ricorda come il Vescovo Orso avesse consacrato la Basilica lo stesso giorno di Pasqua e l’avesse dedicata alla Resurrezione di Cristo: ‘Da lui era stata dedicata la chiesa e chiamata Anastasis‘.
La Capsella di Quirico e Giulitta
Accanto al calendario, nella stessa sala, è una piccola urna di marmo di V secolo. Essa proviene dalla Chiesa di San Giovanni Battista di Ravenna e, secondo la tradizione, custodiva le reliquie dei Santi Giulitta e Quirico, madre e figlio, che la leggenda agiografica vuole originari di Iconio in Asia Minore (attuale Turchia) e martirizzati a Tarso sotto la persecuzione di Diocleziano nel 304. Numerosissime sono le versioni della loro Passio, segno della diffusa devozione a questi due martiri. Il loro culto sarebbe stato portato in Occidente da San Germano, vescovo di Auxerre, all’inizio del V secolo, e successivamente, nel VI secolo, a Roma grazie alla traslazione delle reliquie da parte di papa Vigilio.
La capsella presenta, in un leggero bassorilievo, temi iconografici frequenti. Sui lati corti abbiamo la traditio legis e Daniele nella fossa dei leoni.
Quest’ultima è una immagine consueta che simboleggia la salvezza del giusto che nella persecuzione si affida a Dio. Spesso associata ad un contesto funerario evoca la speranza nella Resurrezione: come Daniele è uscito indenne dalla fossa, così il giusto riceverà la vita eterna. Egli, tra due feroci leoni, è rappresentato nella classica posa dell’orante con le braccia alzate e le palme delle mani rivolte al cielo, in un atteggiamento di totale fiducia a Dio. All’estrema destra, emerge la figura del profeta Abacuc che fedele al comando divino, porta del cibo a Daniele (Dn 14, 31-42).
La scena della tradizio legis, evidenzia la consegna della legge ai principi degli apostoli, in questo caso a Pietro, quali depositari del mandato di Cristo alla Chiesa. Il Cristo, al centro della composizione, ha la destra sollevata nel gesto della parola mentre regge nella sinistra il rotolo che Pietro accoglie. Speculare a Pietro è l’apostolo Paolo che tiene nella sinistra il rotolo mentre con la destra compie il gesto dell’acclamatio.
Nei lati lunghi sono le scene dell’adorazione dei Magi e l’apparizione del Risorto alle donne, immagine quest’ultima che si unisce a quella dell’ascensione: il Cristo poggia il piede su una roccia e si protende verso il cielo ove è la mano del Padre. Sulla destra è la città di Gerusalemme (Mt 28,9-10- Lc 24, 50-53).
I Magi (Mt 2, 1-12) che offrono i doni al Bambino sono evocativi di un profondo messaggio teologico, chiara testimonianza della fede ortodossa in Gesù vero Dio e vero uomo. Il Liber Pontificalis, a commento della figura dei Magi, che il vescovo Agnello aveva messo nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, spiega il senso profondo dei loro doni:
‘I tre doni preziosi contengono in sè i misteri divini, e cioè l’oro significa il potere regale, l’incenso la figura sacerdotale, la mirra la morte, per mostrare in tutto questo che è lui che ha preso su di sè le iniquità degli uomini, cioè Cristo’.
La Cappella Arcivescovile di Sant’Andrea
All’interno dell’episcopio, come una gemma preziosissima, è custodita la cappella Arcivescovile di S. Andrea. Un vestibolo rettangolare immette all’interno del piccolo oratorio a croce greca.
Voluta da Pietro II, vescovo tra il 494 e il 519 – anni particolarissimi per la presenza gota-ariana che contrasta la chiesa ortodossa – nasce come luogo di preghiera privata dei vescovi di Ravenna. Un carme in esametri latini accoglie chi entra:
La luce o è nata qui o qui, catturata, libera regna. Davanti a noi sta la luce, da cui venne l’attuale splendore, e qui racchiusa sfolgora la luce sfuggita all’Olimpo. Guarda come scintillano i marmi e come tute le pietre hanno celesti riflessi di porpora. Splendidi appaiono per il loro valore i doni offerti da Pietro. A lui l’onore, a lui il merito hanno concesso di costruire piccoli ambienti che in spazi ridotti possono superare in bellezza quelli ampi. Per Cristo nulla è limitato. Bene possiede una piccola sede colui che ha un tempio nel suo cuore umano. Fondamento è Pietro e un altro Pietro è il costruttore del’aula. Quel che è la casa, ciò è il padrone; quello che è l’opera, lo è l’esecutore stesso, per la vita e per le opere. Il possessore è Cristo che ponendosi mediatore tra i due li rende un solo essere. Chi viene qui versi lacrime destinate a produrre gioia e rinsaldando il cuore contrito col battersi il petto, non si avvilisca, ma si prostri a terra e ai piedi del medico riveli le sue malattie segrete, perché la cura è vicina. Spesso la paura della morte diventa origine di vita beata (traduzione dal testo latino di M. PIERPAOLI).
Il testo, tramandatoci dal Liber Pontificalis, è stato riportato in pittura durante i restauri curati da Giuseppe Gerola a partire dal 1911. Sulla sinistra è ancora visibile una traccia dell’originale scritta in tessere musive.
La volta del vestibolo presenta su fondo oro, in un raffinato intreccio di gigli e rose, uccelli variopinti di varie specie.
Una delle immagini più significative, anche se profondamente restaurata, è la figura del Cristo sopra all’ingresso del vestibolo.
Giovane, imberbe, in abiti militari con la croce gloriosa sulle spalle regge nella mano sinistra il codice aperto sul quale è scritto un versetto del vangelo di Giovanni: ‘Ego sum via, veritas et vita’, Io sono la via, la verità e la vita’ (Gv 14,6). Egli calpesta la testa al leone e al serpente, simboli del male: ‘Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi‘ (Sal 90,13). La stessa iconografia compare in uno stucco del Battistero Neoniano, immagine significativa all’interno del contesto battesimale in cui si trova, segno della vittoria di Cristo sulle potenze del male. Inoltre il Cristo che calpesta il leone e il serpente è visibile anche nel Sarcofago Pignatta custodito nel Quadrarco di Braccioforte, accanto alla Tomba di Dante.
Entrati nella cappella, al centro della volta a crociera, è il monogramma di Cristo, Iesus Xristos sorretto da quattro angeli. Nelle vele, su fondo oro, sono i simboli dei quattro evangelisti che reggono il prezioso codice del Vangelo: l’angelo simbolo di Matteo, l’aquila di Giovanni, il leone di Marco e il toro di Luca.
I sottarchi in asse con l’altare mostrano i volti dei dodici apostoli racchiusi in semplici clipei: al centro di essi è il Cristo giovane, imberbe, vestito di porpora.
Nell’arco più prossimo all’abside abbiamo Pietro, Andrea, Filippo, Paolo (1 Cor 15, 8-11), Giacomo e Giovanni; l’arco all’ingresso presenta Tommaso, Matteo, Bartolomeo, Giacomo, Taddeo, Simone il Cananeo (Mt 10, 2-4).
Nei sottarchi laterali, disposti simmetricamente rispetto al monogramma di Cristo, a destra sono i santi, a sinistra le sante.
La croce al centro del cielo stellato è una immagine completamente eseguita a pittura, frutto del restauro condotto da Gerola.
Nelle lunette, in sostituzione di mosaici da tempo perduti, sono, anche se molto rimaneggiate, le pitture, del ravennate Luca Longhi (1507-1580). A sinistra è il compianto sul Cristo deposto dalla croce (Lc 23, 50-56), a destra l’Ascensione (Lc 24, 50-53).
Questa cappella, per secoli cuore dell’episcopio, è stata testimone di eventi significativi della recente storia della nostra Diocesi. E’ qui infatti che il 6 giugno del 1903, il servo di Dio don Angelo Lolli, fondatore dell’Opera Pia di Santa Teresa, ricevette l’ordinazione sacerdotale dal Beato (Santo il 23 ottobre 2011) Guido Maria Conforti, fondatore dei Missionari Saveriani, Arcivescovo di Ravenna dal 1902 al 1904. L’altare invece porta la firma dell’Arcivescovo Giacomo Lercaro, suo dono durante gli anni di episcopato ravennate (1947-52) prima di diventare Cardinale di Bologna. Sul fronte dell’altare, una iscrizione, ricorda la dedicazione: ‘JACOB II LERCARO ARCH. EREXIT IN TIT. FUDITQ. OLEŪ DESUPER MCMXLVIII’.
Nelle sue memorie per i 50 anni di sacerdozio, ricordando gli anni a Ravenna, Lercaro ebbe a scrivere:
‘Dirò subito che, per un complesso di circostanze che amo pensare graziosa opera della Provvidenza, non ho, se non raramente, celebrato la S. Messa senza la presenza di una Comunità: primo periodo del mio Episcopato Ravennate, passato dalla Parrocchia popolosa all’Arcivescovado silente, mentre ancora non avevo una famiglia adottiva, sarei rimasto profondamente sconfortato da quelle Messe solitarie, se l’ambiente della vetustissima Cappella di S. Pietro Crisologo, avvivata dai mosaici del V secolo, non avesse supplito con la ricchezza delle memorie alla mancata presenza della «Familia Dei »… La quale poi venne ‘ e doveva venire! ‘ e crebbe; e doveva pur crescere, perchè il dialogo tra l’altare e l’assemblea potesse essere costante, quotidiano, affiatato‘.
Giovanni Gardini
Commissione d’Arte Sacra Diocesana
giovannigardini.ravenna@gmail.com
ARTICOLI CORRELATI:
Museo Arcivescovile: storia e collezioni