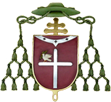Dal “RisVeglio Duemila” N. 31/2015
Nella prima cappella a destra della chiesa di San Domenico, inciso su una lapide marmorea decorata con simboli paleocristiani, è un breve testo che ricorda e sintetizza l’opera del sacerdote ravennate Giuliano Berti: “Giuliano Berti parroco di San Domenico letterato ed archeologo fra le tenebre dei secoli più remoti investigando l’origine di Ravenna scrisse memorie erudite cercò le vestigia delle sue mura dei corsi de’ fiumi dei templi e de’ palazzi pervenuto all’età d’anni LXVII non dall’affaticar lungo affievolito dalle sventure s’addormì nel Signore il primo di novembre MDCCCLXXX. Pochi amici fecero”.
Giuliano Berti era nato a Sant’Alberto, paese della campagna ravennate, il 16 maggio 1814 da Giovanni Berti e Madalena Bianchedi e venne battezzato in quello stesso giorno con i nomi di Giuliano, Gregorio, Giacomo. Nel 1937 ricevette il sacro ordine del presbiterato dall’Arcivescovo Chiarissimo Falconieri (1826-1859). Se il Liber Ordinationem (1832-1902) ed i documenti conservati presso l’Archivio Storico Diocesano di Ravenna-Cervia ci informano del suo cammino verso il presbiterato, poco al momento sappiamo della sua vita. Un accenno alla sua infanzia ci viene dalla dedica rivolta alla contessa Maria Ponti Pasolini posta a introduzione della sua opera sulla Basilica Petriana. Lì il Berti accenna alla sua infanzia e alla generosità della nobile famiglia: “Perciocchè fanciullo e poveretto, e pure tutto volontà di coltivarmi cogli Studii, io non ne aveva modo; e mi sarei perduto, come troppi altri nella mia condizione. Se non che ciò non sofferse l’Avolo del Conte Pietro, vostro marito; e, saputo del mio buon desiderio, mi aiutò così che io fui allogato in questo Seminario. Di qui ogni mio bene e come Cristiano e come Cittadino: e di qui ancora una gratitudine profonda verso il mio Benefattore, e verso la sua Famiglia, in ogni Persona della quale io veggo Lui stesso”. Se la sua biografia al momento rimane lacunosa, lo stesso non può dirsi per la sua bibliografia che possiamo ricostruire nelle sue linee essenziali individuando inoltre un filone legato alla storia e all’archeologia locale. Le sue opere più significative soprattutto a carattere ravennate, opere per le quali il Berti merita di essere ricordato, appartengono sostanzialmente all’ultima fase della sua vita fatta eccezione per la Descrizione del Mausoleo di Galla Placidia, in Album, del 1856. E’ del 1875 infatti la Dissertazione del parroco Giuliano Berti sulla Basilica Petriana in Classe e sui musaici testè rinvenuti in quelle località, col prospetto di un lavoro da pubblicarsi sopra Ravenna antica, primo lavoro di carattere “archeologico”, un’opera che si pone come premessa – è il Berti stesso a dichiararlo – ad uno studio più vasto, rimasto in parte inedito. Gli intenti di questo lavoro corrispondono al desiderio di colmare una lacuna nel campo delle ricerche: «Insomma noi non abbiamo una descrizione né di Ravenna antica, né de’ suoi antichi dintorni: e, se gli Storici accennano a qualche edifizio, od a qualche località, novanta delle cento volte vi accennano il falso, od almeno inesattamente: tanto che è incerto se più sia da lamentarsi o del loro parlare, o del loro tacere (…). Ecco poi l’idea del mio lavoro, che io divido in tre parti, a seconda dei tre principali bisogni della nostra Storia. Nella prima, discorrerò ordinatamente quanto di certo mi è venuto di trovare, riguardo ai mille e seicento anni di Ravenna, che precedono la nascita di Cristo. Nella seconda, descriverò ed illustrerò tutte le località e gli edifici de’ suoi dintorni. Nella terza poi, descriverò ed illustrerò le sue mura, le sue porte, le sue torri; e quanto ebbe nell’interno di fabbriche, così religiose come civili».
Uno degli aspetti da notare, almeno come discorso di metodo, è l’attenzione al dato archeologico, più volte richiamata nel testo, anche se spesso come pretesto.
La dissertazione sulla Petriana nasce dal ritrovamento di alcuni lacerti musivi rinvenuti nelle vicinanze della Basilica di Sant’Apollinare in Classe e da una discussione avvenuta in sito con un Signore, il cui nome rimane ignoto, che lo aveva interpellato in seguito alle scoperte effettuate sull’identità della Basilica rinvenuta: “ci accordammo di trovarci insieme sul luogo il giorno 14 [aprile 1875]”.
Ravenna nei primi tre secoli dalla sua fondazione, opera edita nel 1877, si pone dunque come l’inizio, ovvero la prima parte, di quella grande opera annunciata dal Berti il cui intento era quello di celebrare le glorie della città di Ravenna mettendo in risalto anzitutto la sua fondazione che “non di poco precede l’Era Cristiana”. L’opera consta di XXXI capitoli, a cui fa seguito un’appendice nella quale si evidenziano i rapporti tra Roma e Ravenna. Alla sua pubblicazione concorse il Consiglio Comunale attraverso lo stanziamento di L. 1000.
A questo lavoro fece seguito, nel 1879, un testo sugli Antichi porti militare e commerciale, antico andamento del mare e dei fiumi e minori porti ed approdi nel circondario di Ravenna.
Del 1880 è l’opera Sull’Antico Duomo di Ravenna e il Battistero e l’Episcopio e il Tricolo. Il testo edito dalla Tipografia Calderini, in realtà è un estratto di un’opera più ampia – Ravenna nelle sue mura e ne’ suoi edificii sacri e profani fino a tutto il quarto secolo – e come tale si presenta. I capitoli sono numerati a partire dall’VIII che tratta della Basilica Ursiana, tralasciando così i precedenti capitoli introduttivi. L’estratto, incentrato sul complesso episcopale ravennate, venne edito come omaggio, da parte «dei parrochi della città e sobborghi di Ravenna», al Cardinale Giacomo Cattani (1879-1887) in occasione del primo anniversario del suo episcopato ravennate.
Dell’opera completa era già uscito in data 25 febbraio 1880 il Manifesto di Associazione dove ne veniva illustrato il progetto. Essa si poneva come il prosieguo ideale della Ravenna nei primi tre secoli, a cui avrebbe fatto seguito una terza parte incentrata sul V secolo “attesochè la nostra città agli inizii appunto del quinto secolo ingrandì a quattro volte più che non era, e mutò faccia”.
Uno degli aspetti più interessanti e innovativi va ricercato nella volontà di restituire un’immagine diacronica della città di Ravenna anche attraverso la realizzazione di carte topografiche, delle quali purtroppo non abbiamo notizia: “A cosa finita, avverrà poi che ogni Cittadino, come se fosse resuscitata dalle sue profonde rovine, si avrà dinnanzi Ravenna, quale era dieci, o quindici, o venti e più secoli fa, sapendo accertatamente che qui vedevasi una piazza, là incontravasi un regio palazzo, altrove un pubblico bagno, od un portico, od un anfiteatro, e via via quanto di edifici costituivano una città di quel pregio e di quella gloria che fu la nostra. Il libro proverà l’esistenza di tali edificii, e coi debiti argomenti indicherà i luoghi dove sorgevano; e perché le indicazioni siano meglio seguite dal Lettore, gli si daranno apposite Carte topografiche nelle quali vegga distintamente ed il tutto e le parti singole di Ravenna all’epoca di che si ragiona” (dal Manifesto di Associazione).
Dell’opera, rimasta per la maggior parte inedita, si conserva il manoscritto presso la Biblioteca Classense di Ravenna, il quale venne acquistato – così ci informa il Miserocchi, dal Consiglio Comunale di Ravenna con delibera del 24 aprile 1884. Esso consta di cinque parti: Intorno alle Mura di Ravenna ed a suoi interni Edificii all’epoca di Giulio Cesare fino a tutto il IV sec. dell’era cristiana (da questa prima sezione è tratta la parte monografica sul complesso episcopale); Abbozzo di una storia delle Mura di Ravenna; Abbozzo di una storia delle Mura, Porte e Torri di Ravenna; Cenni e Memorie Storiche sulle Porte e Torri di Ravenna; Miscellanea di Notizie Storiche intorno le Mura, Porte, Ponti, Strade, Regioni, Edifici e Avanzi di Ravenna.
Memorie patrie tratte dalle Cronache dell’Abate Fiandrini et altre è un altro manoscritto del Berti, mai dato alle stampe, un testo suddiviso sostanzialmente in due parti, comprensivo dell’indice della prima sezione. Anch’esso è conservato presso la Biblioteca Classense, dove è arrivato probabilmente come lascito di Sante Ghigi.
Il sostegno del Municipio per la pubblicazione dell’opera Ravenna nei primi tre secoli dalla sua fondazione come l’acquisto postumo di parte dei suoi manoscritti da parte del Consiglio Comunale rendono evidente, in una Ravenna di fine secolo non certo favorevole all’istituzione ecclesiastica, un’attestazione di stima che possiamo riassumere attraverso le parole che Filippo Mordani nel 1872 rivolse al Berti: «Proseguite dunque ad amare la patria, come fate, e ad onorarla co’ vostri scritti».
Da ultimo va ricordato come F. W. Deichmann, negli Indices della sua monumentale opera su Ravenna, ebbe modo di citare gli scritti di Giuliano Berti con particolare attenzione a quelli sulla Petriana e sul complesso episcopale ravennate.
Prof. Giovanni Gardini
Consulente per i Beni Culturali della Dicoesi di Ravenna-Cervia
https://giovannigardini.wordpress.com
giovannigardini.ravenna@gmail.com