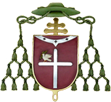Le collezioni del Museo Arcivescovile/1
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 13/2011
Gli ambienti museali
Da questo numero di ‘RisVeglio Duemila’ iniziamo a commentare i materiali del Museo Arcivescovile di Ravenna. Tuttavia prima di procedere nel discorso vale la pena soffermarsi brevemente su tre planimetrie che mostrano chiaramente come al desiderio di ampliamento delle collezioni abbia fatto seguito un fattivo impegno di ristrutturazione dei locali destinati allo scopo museale.
La prima planimetria, tratta da La Metropolitana di Ravenna evidenzia, come già abbiamo avuto modo di osservare nei numeri precedenti, la presenza del Museo all’interno della grande sala che nel settecento costituiva l’accesso alla Cappella di Sant’Andrea.
La seconda, tratta dalla guida Bendazzi-Ricci, indica in maniera decisa un ampliamento degli spazi museali iniziato a partire dai lavori condotti da Gerola nel 1911, ampliamento continuato con Mons. Mazzotti e rimasto consolidato fino al Giubileo del 2000.
La terza pianta, che rende ragione dell’allestimento inaugurato nel 2010, evidenzia un allargamento del Museo innanzitutto negli ambienti del primo piano che ha recuperato le due stanze accanto alla sala precedentemente detta ‘delle pianete’, ambienti che per anni erano stati destinati all’abitazione del custode. Inoltre risulta evidente come gli ambienti corrispondenti del piano superiore, occupati fino agli anni ’90 dall’Archivio Arcivescovile, siano stati adibiti alle collezioni.
La complessità degli ambienti dell’Episcopio è percepibile nella misura in cui si osservano con attenzione le strutture degli ambienti espositivi, concentrandosi in particolar modo sulla torre Salustra, la Cappella di Sant’Andrea, la Sala Medioevale.
La Sala del Lapidario Farsetti
La grande sala di ingresso, meglio conosciuta come Lapidario Farsetti, è ‘ come già abbiamo avuto modo di dire negli articoli precedenti – il luogo della prima raccolta museale voluta dall’Arcivescovo Niccolò Farsetti (1727-1741) nella prima metà del ‘700.
Il nuovo allestimento del Lapidario, curato dalla Dott. Paola Novara, include sostanzialmente i materiali del primo nucleo settecentesco che accoglieva marmi provenienti dalla demolizione dell’antica Basilica Ursiana, in particolar modo le iscrizioni del pavimento. Nella nuova collocazione la scelta è stata quella di mettere le iscrizioni in ordine cronologico partendo dall’età romana (iniziando dalla destra di chi entra) fino all’epoca medioevale.
Le transenne
Colpiscono subito l’attenzione di chi entra nella prima sala cinque delle sei transenne di VI secolo appartenenti alla collezione del Museo Arcivescovile. Esse si impongono al visitatore per il loro raffinato traforo testimonianza di una grande arte legata ad una produzione costantinopolitana. Reimpiegate nel pavimento della cattedrale settecentesca, lì rimasero fino agli ultimi anni del XIX secolo, quando, recuperate, furono esposte prima negli ambienti del Duomo, poi del Museo.
Parte della critica ritiene che esse siano state impiegate nel VI secolo nei lavori riallestimento della zona presbiteriale operata dal vescovo Vittore (536-544). Il Liber Pontificalis ricorda in particolare un prezioso ciborio d’argento che egli avrebbe collocato sopra l’altare della basilica Ursiana.
Nella biografia di Vittore leggiamo: ‘Fece anche un ciborio d’argento sopra l’altare della santa basilica Ursiana, così chiamata dal nome del costruttore, opera meravigliosa. Altri dicono che lo fece insieme col popolo e altri che, ai tempi del vecchio imperatore ortodosso Giustiniano, gli avesse suggerito di aiutarlo, perché voleva fare quest’opera. Mosso da misericordia l’imperatore elargì al beato Vittore tutto il reddito di questa Italia in quell’anno. Avendolo ricevuto, questi costruì l’opera come voi la vedete, la quale, tolto il legno vetusto, è fatta di 200 libbre d’argento a peso ufficiale. Sopra gli archi del ciborio stanno scritti questi versi: ‘Questo voto a Cristo sciolse insieme col popolo il sacerdote Vittore, che con suo amore fece crescere la fede nel popolo. La sacra schiera di angeli che cinge questo luogo sacro fa da ministra al vescovo che scioglie il voto a Cristo. La vetustà rimossa ammira l’opera egregia, mentre diventa migliore con più nobile ornamento. Se qui viene un amante della fede cattolica, tosto se ne ritorna ristorato dal tuo corpo, o Cristo’. Col resto del danaro fece fare vasi diversi per la mensa del vescovo: parte di essi rimane ancora oggi. E fece fare una coperta da porre sull’altare della chiesa Ursiana, di oro puro intessuto con fili di seta, assai pesante, che aveva in mezzo un panno di porpora e fra le cinque immagini distinguiamo lì la sua e sotto alla figura del piedi del Salvatore c’è una iscrizione intessuta di porpora: ‘Il vescovo Vittore, servo di Dio, nel quinto anniversario della sua ordinazione offrì questo ornamento nel giorno della resurrezione del nostro signore Gesù Cristo‘ (traduzione a cura di M. PIERPAOLI).
Le transenne del Museo Arcivescovile possono essere messe in relazione con quelle della Basilica di San Vitale (attualmente conservate presso il Museo Nazionale) e con quelle in Sant’Apollinare Nuovo. Lì un pluteo e 3 transenne marmoree delimitano la zona presbiteriale separandola dal resto della navata.
L’uso delle transenne era profondamente legato alla liturgia: esse delimitavano lo spazio più sacro all’interno della basilica dove era collocato l’altare.
Se a Ravenna in nessuna basilica abbiamo transenne conservate in loco (l’allestimento della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo è infatti moderno), vale tuttavia ricordare una preziosa testimonianza iconografica custodita nel Battistero Neoniano risalente al tempo del vescovo Neone (451- 468) committente del mosaico della volta.
Il registro detto del paradiso, alla base della volta, così chiamato per la presenza di una ricca decorazione fitomorfa e di numerosi uccelli che rimandano simbolicamente al giardino del paradiso, presenta al suo interno un’interessante struttura architettonica che evidenzia, in accordo con i lati dell’ottagono del Battistero, quattro etimasie, quattro altari sui quali sono posti i codici dei vangeli e otto seggi.
La struttura architettonica mostra alla base diverse transenne che affiancano le etimasie; esse sono sormontate da colonne e capitelli che reggono un prezioso soffitto a cassettoni. Le transenne del neoniano presentano un raffinatissimo traforo, in particolare quelle dell’etimasia di mezzanotte.
Il sarcofago fra le due sale
Vari sono i frammenti di sarcofago all’interno del Museo, ma l’unico intero è quello visibile tra la Sala della collezione lapidea e delle transenne e la Sala della collezione lapidea e della statua di porfido, collocato esattamente sotto l’arco che mette in comunicazione i due ambienti.
Esso risale al VI secolo ed è entrato a far parte della collezione esattamente 50 anni fa, nel 1961, per volontà di Mons. Mario Mazzotti allora direttore del Museo. L’arca proviene dal Duomo di Ravenna, precisamente dall’altare maggiore all’interno del quale era stato collocato il 15 maggio del 1761 dall’allora Arcivescovo Ferdinando Romualdo Guiccioli (1745-1763) per essere usato come reliquiario. Conosciuto dalla critica non era tuttavia ben visibile. Ricorda al proposito M. Mazzotti: ‘Gli studiosi, che ogni anno convengono a Ravenna per i ‘Corsi bizantini’ dovevano contentarsi d’intravederla (l’arca marmorea) tolta la grata bronzea, dall’apertura ovale, che è sulla fronte dell’altare. Di intravederla come la intravide il Ricci, come più volte l’avevo intravista io: nulla di più. E’ naturale, quindi, che vivo fosse il desiderio ch’essa fosse pienamente cognita a tutti gli studiosi della scultura paleocristiana in generale, di quella ravennate in particolare‘.
I quattro lati del sarcofago presentano temi decorativi cristiani quali la croce, la palma, il monogramma di Cristo, gli agnelli, la fonte dell’acqua. Le immagini centrali dei lati lunghi vanno notate per la loro bellezza e valenza simbolica. I due pavoni che si dissetano all’unica fonte dell’acqua, come i due agnelli che si nutrono dei frutti della palma richiamano la fede nel Cristo, fonte e nutrimento per la vita eterna. Il coperchio, di fattura moderna, reca due epigrafi volute dall’Arcivescovo Ferdinando Romualdo Guiccioli a ricordo della reposizione delle reliquie all’interno.
D O M
SACRAS RELIQVIAS PATRONOR VRBIS RAVENNAE
FERDINANDUS ROMUALDUS GUICCIOLUS CAMALD PATRICIUS RAV
SANCTAE HVIUS METROPOL ECCLESIAE ARCHIEP
IN HOC ANTIQVUO SARCOPHAGO REVERENTER COLLOCAVIT
IDIBUS MAII ANNO MDCCLXI
D O M
FERDINANDUS ROMUALDUS GUICCIOLUS CAMALD PATRICIUS RAV
SANCTAE HVIVS METROPOL ECCLESIAE ARCHIEP
SUPER SACROS HOS CINERES ARAM MAXIMAM
CVM OMNI CVLTU SUO A FUNDAMENTIS EXCITAVIT
ANNO MDCCLXI ARCHIEPISCOPATUS SVI XVII
Da ultimo vale la pena ricordare come nella basilica di Sant’Apollinare in Classe, lungo la navata destra, sia custodito un sarcofago identico a questo, diverso solo nella chiusura costituita da un coperchio semicilindrico lavorato a semplici squame.
Giovanni Gardini
Commissione d’Arte Sacra Diocesana
giovannigardini.ravenna@gmail.com
ARTICOLI CORRELATI:
Museo Arcivescovile: storia e collezioni