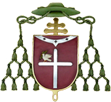4° Lezione del Corso Diocesano di Giornalismo
Dal ‘RisVeglio Duemila’ N. 8/2011
Le contaminazioni fra giornalismo, magistratura e regole dello spettacolo e i pericoli per la libertà sociale e individuale sono stati, giovedì 17 febbraio nella sala conferenze di P.zza Arcivescovado, 11 a Ravenna, i temi della lezione del giornalista e conduttore radiofonico Massimiliano Garavini, nell’ambito del quarto incontro del Corso diocesano di giornalismo, giunto alla sua nona edizione. Cosa significa essere giornalista? Le parole di Garavini hanno indotto tutti i presenti a riflettere sull’importanza dell’obiettività nella trattazione e divulgazione delle notizie.
Esiste un confine sottile fra cronaca, opinione e spettacolo troppo spesso travalicato, creando un guazzabuglio di situazioni o, peggio ancora, una confusioni dei ruoli.
Oggi assistiamo da parte dei giornalisti a uno schieramento a seconda dell’orientamento, che viene dato loro dall’editore del giornale o dal telegiornale per il quale lavorano; in questo modo diventano ontologicamente poco credibili. Cose serissime, come la politica e la cronaca, sono trasformate in show mediatici perdendo così di valore e credibilità.
La spettacolarizzazione della cronaca ha portato alla creazione di mostruosità giornalistiche come il caso di Avetrana: le notizie al servizio delle ‘pruderie’ dei lettori e del pubblico, informazioni date e manipolate in base alle opinioni e ai desideri espressi dalla gente e dai protagonisti stessi.
L’informazione, la vera informazione, dovrebbe essere la cronaca verificata e verificabile dei fatti.
Il compito del giornalista è quello di essere obiettivo, di controllare le notizie e le fonti rendendo inattaccabile ciò che scrive. Intercettazioni, interrogatori e ogni sorta di informazione vengono invece pubblicati senza filtro, senza una verifica oggettiva.
Emergono valanghe di documenti pubblicati e analizzati a seconda della tesi o dell’orientamento adottato, una mole di dati che possono essere interpretati in un modo o all’esatto contrario, risultando non credibili, banalizzando eventi e situazioni che banali non sono.
Chi ha assistito all’interrogatorio di un pubblico ministero o di un magistrato inquirente ha potuto constatare che sono persone rigorosissime, che fanno domande che non lasciano spazio all’interpretazione. A domanda precisa deve corrispondere una risposta precisa, altrimenti viene scartata, infatti al dibattimento solitamente arriva un trentesimo della mole dei dati raccolti.
L’atteggiamento del giornalista, o di chi riporta la notizia, dovrebbe essere esattamente come quello del magistrato: a fonte precisa corrisponde verità precisa, pertanto ‘la verità è vera’ quindi non può essere interpretata.
Il dovere del giornalista è semplicemente riportare una notizia. Partendo dallo stato di diritto esistente, dai propri valori reali e definiti, il giornalista costruisce il proprio modo di riportare l’informazione nel modo più ontologico e neutro possibile, in modo obiettivo e nella massima libertà di espressione, perché questo gli è concesso. Il giudizio morale spetta al cittadino, collocando la notizia nel giusto contesto, definendo l’opinione di chi dà l’informazione e filtrando il tutto attraverso la propria sensibilità.
Un giornalismo vero senza strumentalizzazioni e manipolazioni, che risponda all’esigenza di verità e di fare emergere le cose come realmente sono. Il riappropriarsi di un modo di fare giornalismo che si è smarrito per strada. Avere ben chiaro qual è la bussola dei valori aiuta a tenere dritto il timone, a riportare la discussione nel giusto contesto, arginando la disaffezione dei lettori e,
questa è una mia opinione, ridare speranza, senso della legalità e dell’impegno alle future generazioni.
Giulia Plazzi
ARTICOLI CORRELATI:
5° Lezione del Corso Diocesano di Giornalismo
2° Lezione del Corso Diocesano di Giornalismo
9° Corso Diocesano di Giornalismo